Conversazione con David Wilson in occasione della presentazione del libro in tre parti Shores / Plains / Mountains. Baretto Beltrade, Milano, 7 luglio 2018.
BARETTO
Shores / Plains / Mountains, il tuo nuovo lavoro in tre parti, fin dal nome generico ma nello stesso tempo universale, sembra presentarsi come un’opera che rivolge l’attenzione certamente all’esterno, al territorio che hai deciso di indagare, ma nello stesso tempo a delineare una sorta di piccolo vocabolario personale di forme e spazi fotografici. Cosa ne pensi?
DAVID WILSON
La motivazione principale di questo lavoro in tre parti è quella di distillare o isolare una serie di aspetti che ritengo determinanti, e ridurre tutto all’essenziale, eliminando ciò che perlomeno nell’ambito di questo specifico esercizio potrebbe risultare una distrazione o un ostacolo alla comprensione del lavoro. La scelta tematica, quella dell’indagine su una realtà ben conosciuta e già oggetto di studio in passato, è in linea con questo approccio: la familiarità con i luoghi costituisce una bussola utile a decidere quale sarà la direzione da prendere ma, una volta giunti a destinazione, sarà la consapevolezza che una realtà non si presenterà mai in modo tanto ovvio da annullare quella componente di imprevedibilità e sorpresa. Per accentuare questo aspetto ho spesso voltato le spalle, sia in senso letterale che astratto, ai luoghi e a ciò che essi portavano con sé. Piuttosto, la ricerca era diretta all’evocazione degli stessi, spesso concentrandosi sul dettaglio o sulla mia risposta, intima e personale, allo stimolo. Penso al litorale e più che alle spiagge e al mare, penso all’aria salmastra, alla vegetazione circostante, a ciò che evoca in me come idea. La scelta del bianco e nero, in netto contrasto con l’utilizzo estensivo del colore dei miei precedenti lavori, va esattamente in questa direzione: al posto dell’eloquenza di una sovrabbondanza di informazione, ho preferito concentrarmi su ciò che per me costituisce lo stimolo iniziale, ciò che in qualche modo favorisce quello slancio di curiosità. C’è una ricerca di ordine nelle forme, nelle geometrie, nella corrispondenza tra gli elementi, ma soprattutto c’è la voglia di mettere alla prova le potenzialità del mezzo fotografico, mettendo in relazione la causa e l’effetto, il fatto che procedendo per omissioni, tagli, riducendo tutto alle particelle più minute, si riesca comunque a generare una risposta, in me e (spero) in chi guarda. In questo senso la rinuncia al colore trova una sua logica e viene oltretutto giustificata dall’apparente diversa modalità di assimilazione che la sua assenza comporta: è un digerire più lento e laborioso, ma al tempo stesso quel che rimane ha una marcata persistenza. È un esercizio, appunto, di comprensione di quelli che sono gli elementi essenziali di una propria personale visione, ma è anche un esercizio applicato ai luoghi e alla memoria, quindi diventa anche momento di confronto e di scambio.
 BARETTO
BARETTO
Quello che dici mi pare semplice ma molto profondo. Il bianco e nero, in effetti, sostiene il distanziarsi dei paesaggi nella memoria, per distillare forme ed elementi di base. Il colore è descrittivo, il bianco e nero forse evoca e fissa impressioni e ricordi soggettivi. Riguardando i due progetti ultimati (Shores e Plains), noto la copiosa presenza di elementi verticali, in particolare colonne, tralicci, pali e tronchi. Curioso che un colonnato ricorra sia in Shores che in Plains: mi fa venire in mente la ricerca di elementi strutturali fondativi, non solo architettonici, ma anche archetipici. Dei sostegni visivi in grado di reggere il peso, emotivo e rappresentativo, delle singole immagini. Ricorrono spesso, inoltre, le forme geometriche di base, dalla linea al triangolo al rettangolo, come un voler tornare alle origini della comunicazione visiva, isolandone gli elementi più semplici e primitivi. Un lavoro di astrazione compiuto per lo più sulla memoria dei luoghi, sulle impressioni e ricordi sedimentati.
DAVID WILSON
La questione del colonnato, che si ripresenta anche nello scatto del foro romano di Aquileia in Shores, è interpretabile nel senso cui alludi, quello strettamente compositivo, ma contribuisce anche ad alimentare un possibile sotto-tema, che prende spunto dalla riflessione di Ghirri sul paesaggio italiano, in opposizione alla tradizione pittorialista precedente e parallela o alla versione che dell’Italia compare ad esempio nelle foto Alinari: ritrarre un tabaccaio anziché il Colosseo aveva per Ghirri la funzione di mostrare il Paese realmente vissuto e abitato; ma entro certi limiti ad un certo punto è il paesaggio reale che sembra imitare quello immaginario selezionato dagli Alinari, che infatti ricompare con inserti come il vaso sulla spiaggia in Shores, dall’aspetto classicheggiante, in quell’insegna in ferro battuto dall’aspetto retrò, in quel colonnato del paesino di campagna, o nel filare di cipressi, o nella facciata finto-classica con le statue sul cornicione, in Plains. Ad ogni modo, al di là di questa osservazione che è da considerarsi parallela e accessoria, puramente incidentale, tornando al discorso compositivo c’è effettivamente un convinto ricercare l’elemento geometrico, come a voler completare dei soggetti comunque semplici e marginali, attraverso il frazionamento del fotogramma in riquadri. In questo caso si tratta di una scelta abbastanza elementare, molto vicina ai fondamenti della fotografia di paesaggio e non, dove si cerca in qualche modo di guidare lo sguardo di chi osserva. In altri casi, parecchi, magari si trascurano un po’ quelle stesse regole, cercando una specie di armonia in una somma di elementi che risulterebbero sbilenchi e “sbagliati”, se presi singolarmente.
 BARETTO
BARETTO
I tre ambiti di paesaggio che hai scelto di indagare, già dai titoli di ogni progetto, sono individuati soprattutto da un elemento naturale, geografico: coste, pianure, montagne. Il tragitto sembra chiaro: si comincia dai confini del paese e si risale man mano nell’entroterra. E questi, come tutti i paesaggi, non possono che essere frutto dell’incontro tra natura e cultura, in un rapporto che, chiaramente, è spesso caratterizzato da contraddizioni. A parte pochi casi, in ogni immagine è presente un elemento antropico, che sembra comunicare e relazionarsi in modo molteplice con quello naturale: dal vaso classicheggiante che citavi prima, che valorizza ed esalta la “bellezza” del panorama costiero, integrandosi perfettamente con esso, allo stabilimento balneare che occupa invasivamente tutto il frame. Mi sembra di notare che l’elemento antropico sia più presente in Plains (come è forse più logico aspettarsi, visto che i maggiori insediamenti urbani sono localizzati in pianura). Anche qui, mi sembra di notare, il molteplice registro di comunicazione tra l’elemento antropico e quello naturale: edifici che dialogano in modo armonico con il paesaggio ed edifici che caratterizzano una composizione visiva piuttosto stridente, caotica e disarmonica. I primi appartengono per lo più (almeno secondo me), a un tipo di architettura vernacolare, che si è stratificata nel luogo nel corso della storia, mentre sembra di poter attribuire i secondi a una architettura più recente e di tipo globalizzato.
DAVID WILSON
Partiamo dalla struttura del lavoro, dalla suddivisione in tre fasi/tre fasce geografiche: è un’impostazione molto scolastica, che avrei trovato forse fuori luogo nel caso di un lavoro prettamente descrittivo. In questo caso però, considerato che il materiale ha un valore documentativo secondario rispetto ad altre componenti che abbiamo già parzialmente affrontato prima, quell’impostazione diventa l’unico momento di ordine dell’intero lavoro. La questione dell’elemento umano invece è più varia ed ambigua. Il contesto geografico è molto particolare, è ridotto come dimensioni ma presenta una certa varietà in termini morfologici. Caratterizzante è il rapporto tra quella varietà e le dimensioni appunto, ed è quindi abbastanza logico procedere avvicinando ed accostando quegli elementi, anziché il contrario, anziché isolarli. Mountains è lievemente diverso, poiché tratta di un’area soggetta a un cronico e inesorabile spopolamento, ma fino a un certo punto: che si tratti di me stesso, o di altre figure presagite anche se mai presenti, la tematica del rapporto tra l’uomo e l’ambiente circostante si ripresenta anche quando non è oggetto di una ricerca specifica.
 BARETTO
BARETTO
In “Plains” mi sembra poi che emerga maggiormente la presenza dell’autore, cioè la tua volontà di rivelarla e di renderla esplicita: tronchi ripresi obliquamente, prospettive decentrate, tagli anomali dell’inquadratura, insistenza sul dettaglio, elementi del paesaggio utilizzati a guisa di cornici (anche in “Shores”) che richiamano il dispositivo di inquadramento che è a fondamento dello stesso fotografare. Si tratta di elementi visivi che senza dubbio opacizzano l’immagine, cioè che attirano l’attenzione non sul referente, sul soggetto, ma sull’immagine in quanto tale. La fotografia, in questo caso, pur conservando la propria natura indicale, esibisce anche il suo essere una superficie opaca, cioè un punto di vista soggettivo, riflessivo. È un’impressione che condividi?
DAVID WILSON
È possibile. Ho dedicato una certa attenzione al trovare una continuità tra le varie parti del lavoro, che nelle intenzioni dovrebbero combinarsi in un corpo unico. Quella continuità l’ho cercata nei toni, nelle distanza, negli spazi negativi e non. L’osservazione sui tronchi è molto interessante: risultano obliqui, perché sono obliqui! Mi trovavo in un bosco parzialmente falciato da qualche recente temporale. È buffo che altri scatti, magari con un’impronta diversa, abbiano influenzato in qualche modo la percezione di uno dove, a conti fatti, mi sono limitato a riprendere una scena per come si presentava. Non escludo che possa notarsi una progressione nell’incedere tra i vari lavori, e anzi mi fa molto piacere se questa è l’impressione che se ne ricava: di base si tratta appunto di un esercizio. Un esercizio che prendo molto sul serio, certamente, ma anche qualcosa che nelle intenzioni dovrebbe autoalimentarsi, dal quale io stesso dovrei trarre il beneficio maggiore. Un modo anche per fermarsi, rimettere in discussione e ragionare su cosa voglio. Penso che ne sia il fondamento stesso, partire da A e magari arrivare a B, a C, o chissà dove altro. Quell’opacizzazione, aspetto sul quale non ho mai ragionato, perlomeno in quei termini, la prendo come aspetto estremamente positivo, perché se non altro allude a possibili significati nascosti dietro alla banalità di questo o quel soggetto.
 BARETTO
BARETTO
Cito quanto hai detto sopra: «C’è la voglia di mettere alla prova le potenzialità del mezzo fotografico, mettendo in relazione la causa e l’effetto, il fatto che procedendo per omissioni, tagli, riducendo tutto alle particelle più minute, si riesca comunque a generare una risposta, in me e (spero) in chi guarda». La fotografia è in genere ambigua, racconta in modo contraddittorio e le mancano i verbi. Se vuole descrivere e documentare, deve includere nel frame gli elementi essenziali, altrimenti si presta a dire tutto e il contrario di tutto. Qui è come se cercassi, se ho capito bene, di saggiare il limite, di capire quanto si può tenere fuori dall’inquadratura, quanto si può accorciare la distanza e concentrarsi sul dettaglio e tuttavia conservare il valore comunicativo dell’immagine. Quello che ti proponi non è descrivere un luogo in particolare, ma mostrare gli elementi basilari di qualcosa che, con termine generico e astratto, chiami semplicemente Shores o Plains o Mountains. Io credo che tu ci riesca, in un modo che evita le banalità da cartolina. Scrivi che il tuo scopo non è descrivere, ma evocare. Io credo che tu lo faccia non solo mettendo alla prova il mezzo fotografico, ma anche quello rappresentativo in generale, andando a scavare nelle strutture visive di base.
DAVID WILSON
Penso che la mia risposta allo stimolo sia il vero soggetto, e non è un ripiego o una fuga dall’eventualità di fornire una descrizione letterale ed eloquente, bensì una ricerca volta a comprendere quale sia la funzione primaria del mezzo fotografico, anche solo come strumento. Esattamente come un libro può essere letto ma anche funzionare da sostegno per un tavolo traballante, la macchina fotografica può anche tentare di sovrapporsi o sostituirsi ad altri mezzi espressivi, mettendosi in competizione con essi. È stata in grado di svolgere quella funzione in modo egregio, e continuerà a farlo, ma non è personalmente il compito che le assegno. Il suo compito è per me quello di operare dove altrimenti non potrei arrivare, di favorire attraverso la semplicità dell’atto di fotografare un pieno sfogo di una componente più istintiva, dove l’autore può finalmente essere primo spettatore. Viene messo in conto fin dal principio il contributo del caso nella riuscita di un lavoro. Può suonare magari riduttivo dal punto di vista di un autore, può magari sminuire il suo ruolo, ma a me basta e avanza. Io individuo due fasi principali, quella dello stimolo iniziale e quella della successiva revisione di come quello stimolo è stato registrato su carta. Nella corrispondenza tra queste due fasi, nel riuscito trasferimento dello stimolo, tanto piccolo tanto meglio, sul negativo, è contenuta la gran parte del mio personale modo di intendere la fotografia. Ognuna delle considerazioni precedenti relative agli aspetti compositivi, che potrebbero in prima analisi negare l’approccio appena descritto, sono al contrario in piena armonia con esso, perché sono le forme stesse, le geometrie, le relazioni tra le cose, ad innescare quella curiosità, e quindi finiscono nell’inquadratura in modo assai naturale, per poi essere analizzate nelle loro relazioni ed eventuali corrispondenze, solo in seguito.
 BARETTO
BARETTO
Tu dici: «Il suo compito (della fotografia) è per me quello di operare dove altri non potrebbero arrivare, di favorire attraverso la semplicità dell’atto di fotografare, un pieno sfogo a una componente più istintiva, dove l’autore può finalmente essere primo spettatore (…) Ognuna delle considerazioni precedenti relative agli aspetti compositivi, che potrebbero in prima analisi negare l’approccio appena descritto, sono al contrario precisamente funzionali ad esso, perché sono le forme stesse a innescare quella curiosità, e quindi finiscono nell’inquadratura in modo assai naturale, per poi essere analizzate nelle loro relazioni ed eventuali corrispondenze, solo in seguito». È un’affermazione che mi piace e in cui mi ritrovo: non c’è opposizione tra istinto e composizione, perché sono le forme a innescare la curiosità conoscitiva, le loro relazioni e corrispondenze. È una particolare emozione che coglie di fronte a una particolare veduta, quando spostandoti anche solo di qualche centimetro si crea una specie di corrispondenza in cui qualcosa funziona. Non sono gli oggetti della veduta a contare, sono le linee, le aperture, i rapporti tra masse e disposizioni che costruiscono una particolare soluzione. Non una soluzione generale, ma una soluzione puntuale, la soluzione di quella veduta. E dici: eccola! Poi scatti e magari hai valutato male perché le forme non sono “ideali” che si palesano belli e finiti, sono reali per cui l’apprendimento è progressivo, non è epifanico. Pian piano impari a riconoscere certe forme e le assimili. Perché? A che fine? A cosa serve? Non saprei dirlo. Tu?
DAVID WILSON
Quello che forse, lentamente, sto provando a fare è isolare non solo il meccanismo che mi porta a ricordare, ma anche e soprattutto quello che mi ha portato a scegliere la fotografia come forma espressiva: alla base c’è la ricerca di uno stato di grazia, credo. La fotografia forse è un trucco, un moltiplicatore di sensibilità, un mezzo per provare a fare della “poesia”, in mancanza dei mezzi e della capacità per fare della poesia vera e propria, quella che si fa con una penna. La semplicità dell’atto fotografico in sé, il ridotto bagaglio tecnico necessario, posto che si sia compreso dal principio in cosa consista quell’insieme di abilità utili ad esprimersi, consente di provare con un certo grado di disinvoltura. La registrazione di uno stimolo non ha bisogno della lucidità dello scrittore, e non deve piegarsi alle tempistiche del pittore. È possibile insomma lavorare su ciò che genera una reazione senza porsi il problema, perlomeno in quella primissima fase, del perché quella reazione si sia innescata. Insomma, lo scopo di questo è mettere una pezza su quelli che sono i miei limiti, le possibilità che potrei avere esprimendomi altrimenti. È un ponte tra quel che sento e quel che vedo.
 BARETTO
BARETTO
Mi viene da pensare ascoltandoti alla fotografia come arte democratica, come scoperta della “foresta democratica” indicata da Eggleston.
Mi chiedo però se a fianco di questa riduzione dell’abilità tecnica necessaria non sia preferibile prevedere una contemporanea amplificazione di una sorta di abilità concettuale, nell’immaginare, nel progettare, nel tenere una coerenza, nel fare quel passo indietro di prospettiva che permetta di farne tre avanti. Cioè, prendere in mano la macchina e uscire a scattare è facile, ma dato che vediamo quasi solo ciò che già conosciamo, è facile così anche riprodurre cliché visivi, elementi di conformismo estetico, riduzioni al minimo comun denominatore del “bello”, dello spettacolare, della facile sorpresa a tutti i costi che produce in realtà una confortante rassicurazione. Usare la fotografia per imparare a vedere ciò che ancora non conosciamo di noi o di qualcos’altro: può essere un diverso modo di descrivere quello “stato di grazia” di cui parli?
DAVID WILSON
Credo serva come prima cosa un catalogo, a maggior ragione se si procede a casaccio. La cosa interessante è che ci sono buone probabilità che quel catalogo progressivamente diminuisca nelle dimensioni complessive. Forse è la conseguenza dell’approccio stesso, a sfogliare quel catalogo qualcosa colpirà più di altro. Qualcosa resterà e troverà il modo di ripresentarsi, altro invece sarà destinato a scomparire, senza troppi drammi. È una questione di guardare, ri-guardare, ed eventualmente assimilare. Esiste poi anche la possibilità, forse la necessità, di completarsi con quello stimolo esterno, di assimilare un catalogo altrui, ma lì l’equilibrio potrebbe farsi assai precario, potrebbe portare a cercare l’immagine e non l’idea, la fine e non l’inizio di un processo. In tutto questo il rischio è di finire nuovamente al centro del lavoro. Chiariamo, penso si sia sempre al centro del lavoro, ma si può esserlo in modi molto diversi tra loro. Penso ad un ruolo, e ci rifletto misurando la questione su di me, senza farne un discorso generale, dove il fotografo è come già detto il primo spettatore. È una fortuna, un vantaggio, un’opportunità non da poco, probabilmente preclusa ad altri mezzi espressivi. Forse pecco di immaginazione, ma mi riesce difficile immaginare di potermi rileggere in un testo e trovare nuovo, “estraneo” quel che ho scritto. Forse potrò compiacermi di questo o quello, certamente, ma mancherà qualcosa. Mi nomini Eggleston, che a quanto pare dichiarò guerra all’ovvio. Io nel mio minuscolo al massimo posso manifestare una certa diffidenza nei confronti dell’intenzione. Fossi più bravo probabilmente la potrei maneggiare con disinvoltura, ma mi rimarrebbe comunque la sensazione che a portarmi troppe cose da casa, mi resterebbe ben poco spazio per quelle che potrei incontrare in giro. E allora vedi che ha senso fingere di parlare di litorali, pianure, montagne, sono il modo per uscire dall’imbarazzo della scelta di una direzione. Il resto probabilmente si è annidato in testa da qualche parte, a forza di riguardare il catalogo mio, o quello altrui. A ripensarci, forse il processo resta parzialmente inconscio anche successivamente, anche nel rivedere. La speranza è che denudarsi un po’ aiuti a trovarsi, a sviluppare una propria visione, a proporre qualcosa che tutto sommato sembri fatto proprio, spontaneo e naturale, senza che si percepisca la pretesa di reinventare la ruota a tutti i costi.
 BARETTO
BARETTO
È interessante quello che dici e mi ci rispecchio. Ti vorrei chiedere se hai avuto l’impressione, se succede anche a te, di pensare che alcune delle cose che fai erano latenti e che prima o poi dovevano venir fuori per forza. E che “vengono fuori” attraverso il linguaggio fotografico e non in altro modo.
DAVID WILSON
È possibile, e anzi lo spero vivamente. Di più, vorrei che restassero in qualche misura tali, anche dopo essersi mostrate. Dovessi essere in grado di comprendere fino in fondo il senso di qualcosa, la ragione di quella reazione che può avvenire in me nel ri-vedere, mi sorgerebbe il dubbio di stare nuovamente virando verso un modo di comunicare diverso. Vorrei che quella componente fosse una presenza costante. Certo, a volte prevarranno aspetti più descrittivi, è nell’ordine delle cose e anzi sono più che favorevole al fatto che da un lavoro si possano trarre significati diversi. Io cerco solo di non perdere di vista quel senso, e concentrarmi su aspetti meno espliciti. D’altro canto ritengo sia anche il mio compito, non posso pretendere che altri dedichino al mio lavoro lo stesso tempo che gli dedico io, non posso pretendere e anzi mi spaventerebbe, se provassero a sviscerarlo con la stessa determinazione. Sarebbe bello che qualcuno ne ricavasse un’impressione diversa, epidermica, ma quel tipo di comprensione passa per processi non necessariamente spiegati o risolti. Io provo a concentrarmi su quelli, che credo siano la parte più complicata, e senza la pretesa di risolverli io per primo. Gli altri, quelli più facilmente assimilabili, li vedo come un effetto collaterale (fortunatamente) inevitabile.





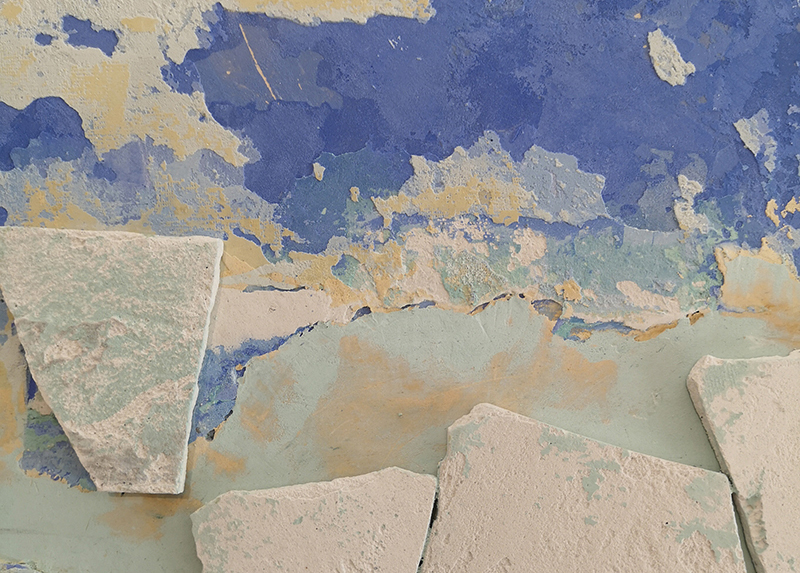


Scrivi un commento