“Supercity”, mostra del Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo a cura di Giorgio Barrera, Renata Ferri e Michele Smargiassi, è il frutto della selezione di migliaia di foto provenienti da alcuni circoli fotoamatoriali dell’hinterland milanese. Una mostra molto riuscita nel suo intento insieme partecipativo, documentario e performativo grazie al lavoro concettuale e di cura e al magnifico allestimento che ne è scaturito.
Questa però, purtroppo, non è una recensione. Non lo è perché, accompagnati nella visita (noi del Baretto) da Matteo Balduzzi, curatore del Museo di rara disponibilità e acutezza, mi sono distratto e mentre passeggiavo tra le foto schedandole mentalmente e facendo e disfando ordini per costruire la mia mappa, ho iniziato a pensare a una cosa un po’ incongrua, e cioè che soprattutto mi veniva da dividere le foto presenti in tre gruppi.
A un estremo, nella mia testa, c’erano le foto fatte in apparenza senza alcuna ambizione estetica o espressiva e che occultavano persino la propria residua intenzione documentaria con una assoluta trascuratezza formale: foto un po’ casuali, insomma, che – per inesperienza o per precisa scelta autoriale non possiamo saperlo – somigliavano a frame estratti da webcam o da fotocamere di sorveglianza automatizzate. Queste foto mi attraevano in modo oscuro in quanto materia grezza: un bravo autore avrebbe potuto ad esempio usarle come materiale d’archivio per costruire vedute originali e vitali di quei luoghi (ma, un momento: l’hanno già fatto, è appunto la mostra che stavo guardando!) o manipolarle a fini piuttosto avanguardistici (uno bravo a farlo: Kenta Cobayashi).
Da quando tutti abbiamo una fotocamera in tasca dentro lo smartphone, questo è il genere cui appartiene il 99% delle foto che vengono prodotte nel mondo: foto “sono qui”, foto “relazionali” scattate per testimoniare e tracciare un passaggio, una presenza in cui spesso l’autore si inserisce come testimone e per indicare alla bolla che ci frequenta il luogo in cui siamo, cosa stiamo facendo, chi sono i nostri affetti o quali sentimenti proviamo.
All’estremo opposto c’erano invece le foto autoriali, a me hanno colpito quelle di Giulia Tini, in particolare una sequenza sulla casa dei suoi nonni e sulle loro persone: foto che manifestavano un semplice e felice intento espressivo perché intendevano raccontare/mostrare qualcosa – un soggetto, un tema, un ambiente, delle persone – in modo personale e ci riuscivano bene: proprio in quanto riuscivano bene nel loro intento – raccontare/mostrare una cosa ben definita e delimitata da un punto di vista ugualmente limitato – veniva da giudicarle belle. Un luogo comune tra fotografi vuole che in fotografia ci sia il buono e ci sia il bello e che tra i due non scorra buon sangue, ma a me è sempre parso un modo per cavarsi d’impiccio non sapendo cosa pensare di preciso. No, quelle foto erano felicemente belle.
In mezzo c’erano le foto più chiaramente fotoamatoriali, quelle cui probabilmente ci sentiamo tutti più vicini, noi mortali: foto fatte con un intento estetico e con attenzione alle regole e ai modelli alti, foto cioè che manifestavano chiaramente l’intenzione di “fare una bella foto” ma che essendo questo obiettivo inteso in senso astratto e generico (ispirandosi cioè a un modello di bello disincarnato, fuori dalla storia, eterno), e poiché tale modello estetico non esiste, non potevano che soddisfare il proprio intento pescando nell’enciclopedia inconscia di ogni singolo fotoamatore, riproducendo così inconsapevolmente (oppure no) gli stilemi cioè le modalità, i tagli, gli approcci e i soggetti già storicizzati di grandi autori del passato. Ecco che allora avevamo pseudo Basilico, finti Ghirri, alter/Bresson e così via. Foto aspirazionali che in quanto tali non possono che risultare inadeguate e fallite quanto più si avvicinano all’obiettivo. I suddetti grandi autori infatti raramente perseguono un bello assoluto. Anzi, non a caso spesso i contemporanei, non del tutto a torto, giudicano “brutte” le loro opere: ci vuole un po’ perché l’occhio collettivo si adegui a una visione o a un soggetto che è entrato da poco nel campo visivo, come la pupilla ci mette un po’ a passare dal buio alla luce o viceversa. Quindi chi le intenda oggi come “belle” in senso assoluto e si ponga in mente – avendole come modello mentale o imprinting – di “farne altre”, non può che fraintenderle nel loro manifestarsi reale e storico.
Le foto con cui Franco Vaccari negli anni ’70 tracciava la propria presenza mentre viaggiava fotografando retro di camion (700 km di esposizione) o la presenza di persone di passaggio in un luogo (Lascia su queste pareti una traccia del tuo passaggio, Biennale di Venezia 1972), di cui ci restano oggi i volti seri o buffi o spaesati prodotti dalla macchina per fototessere, raramente venivano giudicate belle dai fotografi. Eppure con svariati decenni di anticipo quei lavori parlavano del nostro lasciar traccia attraverso immagini che ci scambiamo continuamente. Esplorando quel concetto con accuratezza e con incredibile – visti i parametri della fotografia dell’epoca – coraggio estetico, Vaccari fotografava il futuro ed è difficile non considerare quanto abbia spostato in altre imprevedibili direzioni ciò che può essere detto bello.
Così i ritratti con cui Thomas Ruff mostra il volto umano in modo seriale, agli esteti dell’autenticità paiono anonimi e insulsi, e tuttavia: siamo sicuri che nel suo restare rigorosamente in superficie, la fotografia non sia lo strumento perfetto per mostrare – e quelle di Ruff lo fanno benissimo – le manipolazioni che i dispositivi di controllo fanno delle nostre vite? A partire dall’identità, quanto in apparenza di più intimo e personale.
Da tutto ciò deduco una cosa che sappiamo già: solo la chiarezza rispetto al soggetto (cioè la risposta ben delimitata alla domanda: cosa sto fotografando?) mi potrebbe salvare dal rischio di fare opere aspirazionali, estetizzanti, inconsapevoli o peggio ancora consapevoli doppioni di un frainteso bello assoluto che è solo una delle tante forme in cui il bello si è manifestato una volta in passato e che il mio intento e il mio sguardo hanno trasformato in un cliché distruggendolo, quindi opere fallite, cioè in una sola parola: kitsch (*).
Viceversa senza questa chiarezza la macchina mostrerà implacabile, nella filigrana di ciò che aveva di fronte all’obiettivo, il vero soggetto ossia ciò che aveva dietro di sé ossia la mia incerta e perennemente insoddisfatta e vagamente consapevole ambizione di apparire un buon fotografo. (Perché come é noto la macchina registra quel che ha davanti, ma anche e soprattutto quel che ha dietro, il punto di vista, gli intenti, spesso persino la storia e il colore dei capelli restituiti in forma di retorica nel tessuto dell’immagine finale).
Cos’è quindi questa chiarezza? Torno alle foto di Giulia Tini e mi chiedo cosa mostravano: stava fotografando i suoi nonni e la loro casa, sì ma: stava fotografando la loro vecchiaia, sì ma: stava fotografando la nostalgia che vederli faceva scattare in lei, come se li stesse già rimpiangendo mentre c’erano ancora, quindi stava fotografando la loro assenza negli oggetti di casa e nei loro corpi di scorcio o di spalle, sì ma: stava fotografando il suo dolore e insieme il suo amore per la finitezza delle cose e delle persone, sì ma: stava fotografando tutto questo riferito a sé perché solo riferendolo a sé ognuno può sentirlo intorno a sé. Ecco: la chiarezza sembra uno scavo per isolare un singolo reperto sepolto che forse all’inizio non identifichiamo, o che forse proprio le immagini da subito – o dopo un po’ – ci permettono di vedere.
Ogni autore opera probabilmente a modo suo: forse a volte le foto sono già perfettamente e microscopicamente adeguate alla specifica limitatezza del tema e la consapevolezza di “cosa sto veramente raccontando/mostrando” segue, viene dopo? O a volte forse le due cose procedono assieme per approfondimento progressivo, come se la chiarezza fosse soprattutto una relazione, un rapporto di scambio tra operatore e soggetto, tra proiezioni e ritrovamenti, mediati da una macchina che non è lo strumento diabolico per catturare l’anima autentica e vera che starebbe già là ad aspettarci, nelle cose mute, semmai la protesi con cui costruiamo una reciprocità parlante: inizio pensando di voler fotografare un paese, poi guardando i primi risultati stampati capisco che mi interessano certi cortili vuoti o certi scorci, allora vado più a fondo e successivamente capisco che quegli scorci e quei cortili mi attirano perché sono una metafora di un sentimento che sento ma che non riesco ancora a identificare e ha a che fare con quei luoghi, poi mi ricordo che in un cortile simile ci stavo da ragazzino e che da allora la città è molto cambiata, allora intuisco che forse sto fotografando la trasformazione della città e insieme la permanenza dei miei ricordi… e così via, fino a focalizzare con precisione “cosa sto fotografando”, a nominarlo e a fotografarlo (a fotografarlo per poterlo vedere e nominare).
Forse allora quelle foto saranno adeguate a raccontare/mostrare il tema, la situazione, la realtà che ho individuato. Il che, beninteso, non ne fa necessariamente delle opere di valore, anzi: ma evita loro, per lo meno, di essere per me completamente inutili.
SUPERCITY! Cusanello San Dugnano
a cura di Giorgio Barrera, Renata Ferri, Michele Smargiassi
Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balssamo
20 giugno – 14 ottobre 2018
(*) Ciò che Milan Kundera ha così precisamente definito: il Kitsch è la negazione assoluta della merda. In senso tanto letterale quanto figurato: il Kitsch elimina dal proprio campo visivo tutto ciò che nell’esistenza umana è essenzialmente inaccettabile. Quindi il Kitsch si pone come l’ideale estetico dell’accordo categorico con l’essere (dove la merda è negata). L’ossessione di star lontani dal kitsch è peraltro come è noto la sua manifestazione più radicale. È forse per esorcizzare al cubo questo pericolo e la propria falsa coscienza verso la cultura di massa che era nato il postmodernismo, con la sua adesione sfrenata al rimosso. Ma con esiti ancora tutti da valutare.



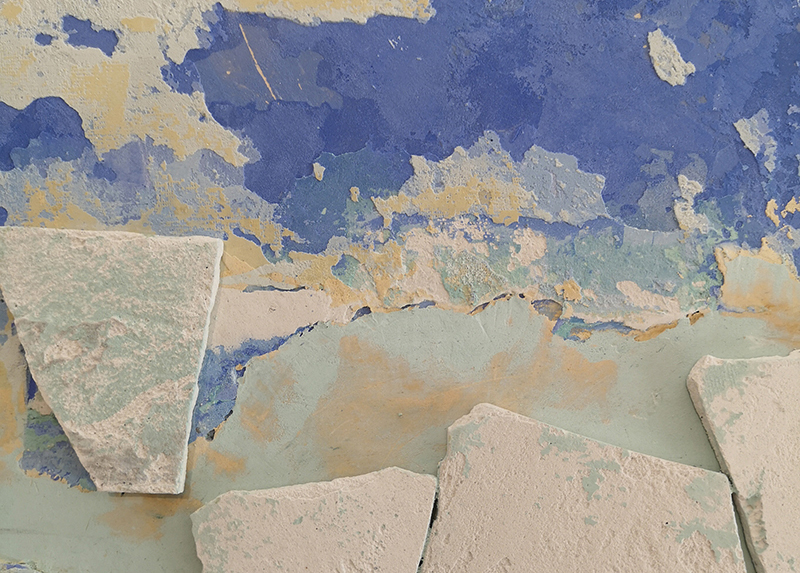


Scrivi un commento