A partire dai tardi anni Settanta, Jeff Wall allestisce nei suoi lavori dettagliate scenografie che imitano situazioni “reali” o che ne creano di nuove e lo fa ricorrendo ad attori, a installazioni, spesso a complesse elaborazioni in postproduzione digitale in cui assembla centinaia di scatti.
Attraverso scenari finzionali Wall, nello stesso tempo, affronta complesse tematiche di tipo sociale o filosofico e riflette “metafotograficamente” sul valore di verità della fotografia, grazie al continuo riferimento alla storia dell’arte e alle citazioni mai gratuite presenti in tutti suoi scenari.
Con i suoi lightbox esposti in tutto il mondo, Wall è stato uno dei primi fotografi/artisti capace di emanciparsi dall’idea di fotografia “parente povera della pittura” capace al più di ricavarsi una nicchia orgogliosa ai suoi margini, e la sua opera è piuttosto uno degli esempi di come il rapporto si sia quasi ribaltato negli ultimi decenni.
Come è accaduto ad altri suoi colleghi, esponenti del filone “staged”, anche la fotografa di Wall è stata a volte guardata con sospetto perché esplicitamente, programmaticamente finzionale. «La fotografia – dice un pensiero ancora piuttosto comune – deve cogliere lo stato d’animo, deve cogliere l’istante e il “ciò che c’è”; se è costruita verrà apprezzata magari per la qualità tecnica, ma non può emozionare, non è Fotografia con la maiuscola». Sorvolando sul termine “emozione” – che le stesse persone userebbero con molta più circospezione per la letteratura o il cinema, sapendo che in quei campi sarebbe probabilmente sinonimo di prodotto di dubbia qualità destinato a un pubblico di bocca buona – la questione dell’attimo, reale o irreale che sia, si ripropone invece all’attenzione come un peperone mal digerito.
Il peperone in questione si compone di due fasi, perché lo scatto dell’otturatore registra contemporaneamente, come è noto, due cose: ciò che sta davanti all’obiettivo – il soggetto fotografato – e ciò che sta dietro – l’autore, le sue intenzioni coscienti e incoscienti, la sua collocazione, il punto geografico, mentale, sociale e culturale da cui sta guardando. La foto che ne risulta non è quindi solo un “qualcosa è stato lì”: è anche “qualcuno l’ha visto”. La fotografia è ambigua, doppia e proprio per questo è interessante: non è solo prelievo istantaneo, traccia fisica di “qualcosa”, indice, ready made (messaggio senza codice, come diceva Barthes) ma è anche linguaggio e costruzione.
La fotografia, sembra dirci Wall, ha già connaturata in sé una capacità di illusione, tanto è vero che spesso ne approviamo a scatola chiusa un presunto contenuto di verità o la scambiamo tout court per “la realtà” di cui è traccia o rappresentazione: guardando la foto di un tramonto e richiesti di dire cosa sia, diciamo: “è un tramonto”, quando invece è solo una fotografia del tramonto, cioè una realtà del tutto diversa da quella, in genere rettangolare e a due dimensioni. Riteniamo rilevante e ci occupiamo solo di ciò cui la fotografia rimanda (i soggetti, che devono quindi essere importanti, forti, o per lo meno belli), trattandola così da finestra trasparente, sorvolando invece sul suo esserne un’immagine, prodotta da una macchina che in quell’atto incorpora saperi, atteggiamenti, ideologie, contesti, discorsi (spesso, come ricorda Vaccari, senza che gli “autori” ne sappiano granché) e ce li restituisce sotto l’apparenza del “reale”.
Forse è per questo che la soluzione adottata da Wall e poi ripresa da molti altri è diventata così rilevante: perché ha messo a tema questo invisibile decisivo, l’ha opacizzato, l’ha esibito. Forse si dovrebbe allora ribaltare il giudizio comune: non considerare la condizione ambigua della fotografia come possibilità virtuosa o usarla in modo naturalistico (per “cogliere l’attimo reale” pensando di averlo così catturato, quando invece nel migliore dei casi hai catturato solo la sua sparizione, la sua perdita, la sua assenza) è un modo un po’ scivoloso, a volte inconsapevole – ma naturalmente legittimo – di fare fotografie. Invece che restringere, si dovrebbe provare ad allargare lo sguardo e accettare che l’evoluzione è contaminazione, flusso, apertura, non rispetto meccanico di regole che si vogliono permanenti e non lo sono.
Qualche fonte sul web:
http://www.artribune.com/…/video-jeff-wall-intervista-foto…/
https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2007/jeffwall/
Gestus, raccolta di scritti di Wall tradotta in italiano da Quodlibet: http://www.quodlibet.it/libro/9788874624966













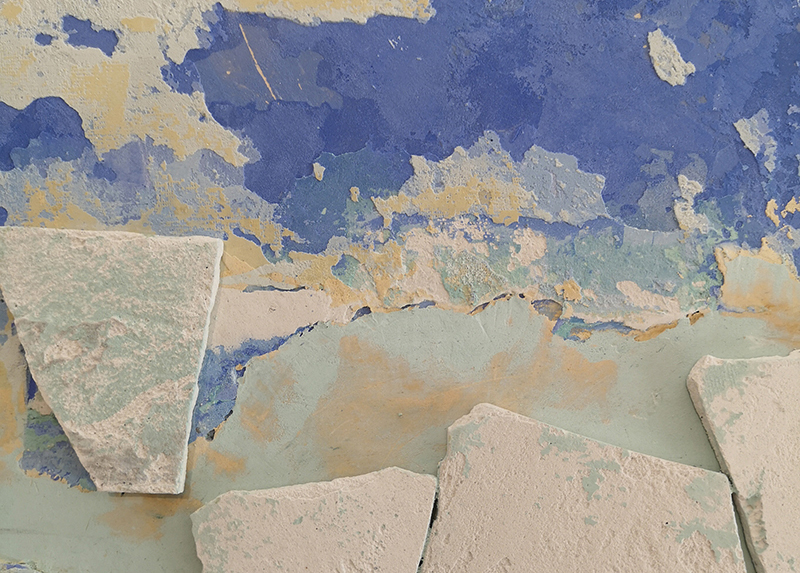


Scrivi un commento