«I don’t care about good photography, I care about complete honesty». La fotografia di Nan Goldin si potrebbe riassumere con questa sua dichiarazione. Perché è di questo che si tratta: una dichiarazione, un giuramento, una promessa. E una necessità: «Yes, photography saved my life. Every time I go through something scary, traumatic, I survive by taking pictures».
Nan Goldin è indissolubilmente legata al suo lavoro più famoso e importante: “The Ballad of Sexual Dependency” mostrato per la prima volta in pubblico nel 1986 sotto forma di uno slide show di 45 minuti, composto da 750 fotografie accompagnate da una colonna sonora da lei stessa selezionata (Velvet Underground, Nina Simone, James Brown, Charles Aznavour tra i tanti). Si tratta di circa tre secondi e mezzo a slide, ovvero qualcosa con la quale anche i più cinici fotografi amatoriali non hanno mai pensato di torturare gli amici al rientro dalle vacanze.
Anche la Goldin era (ed è, letteralmente) una fotografa amatoriale. Ma non rientrava dalle vacanze con triti tramonti e tuffi dalla scogliera. The Ballad nasce e cresce nel periodo in cui Nan ha vissuto a New York, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, registrando fedelmente la vita di parte della popolazione di gay, transgender, travestiti e drag queen che vibrava nel Lower East Side della grande mela. Non lo fece da reporter o da giornalista, lo fece da protagonista avendo vissuto con alcuni di loro per anni. Tra l’alcol, la droga e quella dolce ignoranza ammantata di incoscienza che portò alcuni dei suoi compagni d’avventura dalla liberazione sessuale dritti nelle braccia dell’AIDS.
Questa è la cornice dentro cui Nan inserisce immagini di amici e amanti nella quotidianità: gli spettacoli drag, le sbornie, la tossicodipendenza, i rapporti sessuali dei suoi coinquilini, il suo volto tumefatto dopo il pestaggio da parte del suo ragazzo, il dolce abbandono delle loro vite che, viste con gli occhi di un cittadino “perbene”, erano ascrivibili alla sottocultura gay e trans ovvero dei reietti, degli emarginati. Le parole di Nan rendono l’idea del suo approccio: «We were never marginalized because we were the world, we didn’t care what straight people thought of us, we had no time for them, they didn’t show up in our radar so we weren’t marginalized from anything».
La Goldin usa la fotografia come strumento per certificare la sua stessa presenza durante un istante, con una persona, in un luogo. Così come era solita annotare su piccoli bloc notes tutti gli argomenti di discussione con gli amici o conoscenti. Era un approccio documentario alla sua stessa esistenza. Era la necessità di creare delle prove di quanto stava accadendo. Questa abitudine, soprattutto fotografica, è scaturita dalla triste vicenda della sorella maggiore, morta suicida all’età di diciotto anni; lutto mai accettato dalla famiglia tanto che, negli anni successivi alla tragedia, i genitori cercarono di creare una vicenda alternativa che non comprendesse il suicidio e attribuendo la morte a una non ben definita malattia.
Pudore, vergogna, anaffettività. Quale che fosse la ragione che portò i suoi genitori a comportarsi così, Nan promise di avere, da allora in poi, sempre a disposizione delle prove per certificare quanto stesse accadendo. Delle prove. Delle foto. Delle foto che non interpretassero o leggessero il soggetto ritratto, semplicemente fedeli riproduzioni della realtà. Ancora Nan: «The camera was like an extension of my hand and I just shot all day. I never moved anything for me and it was a sin to move a beer bottle out of the way; because it had to be exactly what it was and that was really the bottom line about photography for me: to show exactly what it was».



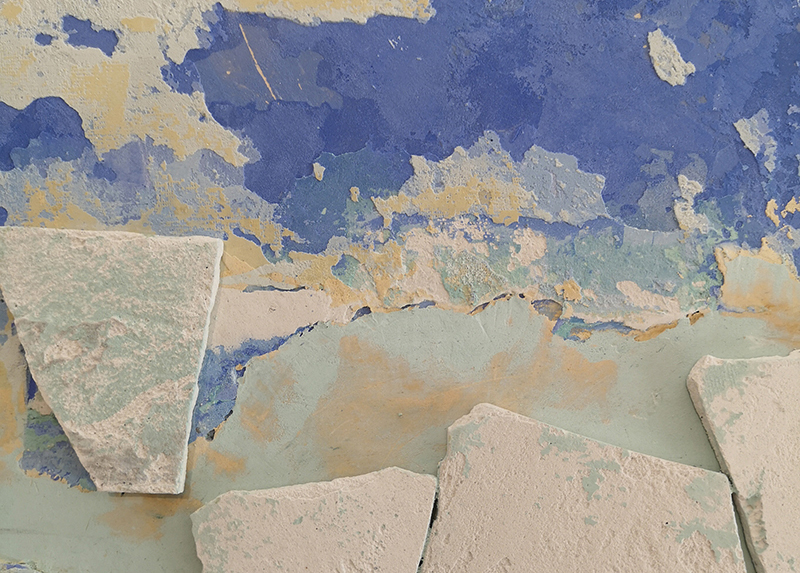


Scrivi un commento