L’opera fotografica di Philip-Lorca diCorcia è, tra le altre cose, un continuo tentativo di forzare i confini tra i generi, e anche una dimostrazione in atto della loro discutibilità e la permeabilità.
Philip-Lorca diCorcia (nato nel ’51) inizia a lavorare quando la tradizione della “fotografia di strada in presa diretta” o “dell’uso documentario a fini artistici” appare a una svolta: scossa dalle fondamenta da grandi innovatori del linguaggio (come Winogrand e Friedlander), messa in questione dalle avanguardie concettuali, che dubitano fortemente dello statuto di verità della fotografia e della sua affidabilità come rappresentazione del reale, messa all’angolo come strumento principe della documentazione dei grandi fatti dalla tv, sembrava impossibile, come racconta Jeff Wall in “Gestus”, «fare qualcosa di meglio» o anche solo rifare per l’ennesima volta le stesse cose dei Grandi Maestri. Occorreva trovare altri territori, altri approcci.
Nei suoi lavori diCorcia pare impegnato proprio ad esplorare i confini tra generi, e tra le relative metodiche esecutive e tra le retoriche dei generi, ad attraversarli producendo ibridi. Non solo quindi fotografie, ma contemporaneamente anche riflessioni sulla fotografia, sui suoi stili, sui suoi format consolidati. Fotografie che, contemporaneamente, mostrano il mondo e il proprio modo di mostrarlo. DiCorcia appartiene quindi alla prima generazione di fotografi che, digerita la lezione dei concettuali, ne applica gli interessi metafotografici all’interno del corpo più classico della fotografia.
In “Hustler”, ad esempio, prodotto tra il 1990 e il ’92, si accosta con stile documentario alla prostituzione maschile lungo il Santa Monica Boulevard a West Hollywood, ma invece delle immagini crude e per così dire “autentiche” che ci aspetteremmo (perché anche l’autenticità è un format, fatto magari di bianco e nero o colore sparati, composizione volutamente sconnessa, primi piani disassati, dolore dipinto sul volto eccetera), allestisce per ogni ritratto un set pubblicitario che restituisce immagini dal sapore decisamente cinematografico, dolenti e sognanti nello stesso tempo. Spiazzanti le didascalie alle foto, in cui indica le tariffa corrisposte a ogni soggetto per ottenere la sua collaborazione nel progetto, che corrisponde a quella dovuta per le sue prestazioni sessuali.
Guarda il libro: Hustler
In “Streetwork” (1993-1997), si cimenta a modo suo proprio con la fotografia di strada. Ecco come costruiva i suoi set, sovvertendo criticamente il rapporto tra i cliché dello spontaneo e del decisivo e la fotografia preparata, andando in cerca di una simulazione di casualità, dell’insignificanza del qualunque, che servisse a decostruire l’ingenuità della fruizione: «Quando arrivo in un posto, prima stabilisco il punto di ripresa. A partire da quello, piazzo una batteria di flash sui lampioni o sulle facciate dei palazzi vicini, sincronizzati con la mia fotocamera con un segnale radio. Testo le luci con una Polaroid. Poi fotografo tutto quello che passa. (…) Io non cerco di catturare sul fatto un cliché. Io cerco di eliminare i cliché. Io catturo dei momenti in cui non accade niente. Non mi interessano i fatti».
Guarda il libro: Streetwork
In “Heads” (1999-2001) costruisce invece un meccanismo semi-automatico con un intento che può addirittura sembrare polemico: una X tracciata su un marciapiede a Times Square, una fotocamera fissa con un potente teleobiettivo puntata da molto distante, flash nascosti su un ponteggio sopra la X e attivati da un radiosegnale: il risultato, dopo due anni di lavoro e 4000 scatti, è una galleria di 17 ritratti street da far impallidire per potere evocativo ed emozionale il più vitalistico amante della “fotografia immersiva a una spanna dal soggetto”. «La mia indagine riguardava da una parte la natura del caso, dall’altra la possibilità di produrre un lavoro che appare empatico, senza in realtà nemmeno incontrare le persone».
Guarda il libro: Heads
E in “A Storybook Life” (2003), che raccoglie scatti fatti nel corso di vent’anni, diCorcia fa in un certo senso la stessa operazione di Streetwork – discutere l’ingenuità della fruizione – ma in modo diverso, costruendo in vitro i “non fatti” di cui prima andava in cerca: allestisce e prepara situazioni di vita tipiche della classe media in cui pare tuttavia voler sorprendere scene di solitudine e desolazione degne di Edward Hopper. O di John Cheever, perché l’intenzione di costruire storie è del tutto esplicita: «Nessuna tra le foto disparate riunite in questo libro – spiega – e scattate nel corso di anni è originariamente stata scattata per essere usata in questo libro. Ordinandole in sequenza ho cercato di indagare le possibilità narrative sia in rapporto a una singola immagine che, soprattutto, nella relazione tra le une e le altre . A Storybook Life è un tentativo di scoprire la possibilità di far emergere significati nell’interazione di immagini apparentemente non correlate, nella speranza che il contenuto possa mutare costantemente in base sia alla condizione esterna che interna dello spettatore, ma rimanga significativo a causa del suo intrinseco, ma latente contenuto. Le decisioni consce e inconsce prese nel corso dell’editing sono il vero lavoro di questo libro».
Guarda il libro: A Storybook Life
Un’intervista qui















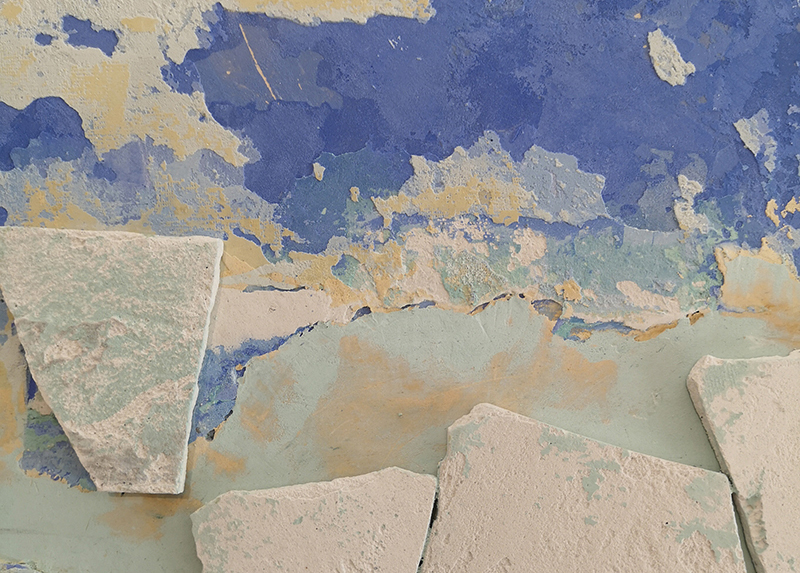


Scrivi un commento