Hidden Islam è un libro fotografico di Nicolò Degiorgis del 2014 pubblicato da Rorhof. Un libro che ha vinto molti premi internazionali, meritandoli ampiamente. Molte recensioni, all’uscita del libro, si sono concentrate sulla sua portata sociale e politica, sulla denuncia della condizione di arretratezza culturale di un territorio. Si tratta di un aspetto fondamentale, certo, ma forse così non si mettono in luce altre implicazioni interessanti, previste dall’autore. Implicazioni che coinvolgono direttamente la fotografia in quanto linguaggio complesso.
Ciò che colpisce di questo libro è anzitutto il suo doppio registro di lettura. Si può sfogliarlo senza aprire le pagine ripiegate e fruirlo come un rigoroso libro di architettura di periferie urbane (non proprio di topografia perché l’inquadratura, spesso ravvicinata, limitata all’edificio o a parte di esso, non permette una visuale allargata sul contesto ambientale e paesaggistico). Si tratta di fotografie di piccolo formato, in bianco e nero, del tutto disabitate, dalle inquadrature severe, razionali e uniformi, che richiamano alla mente la Scuola di Düsseldorf o certi scenari urbani di Basilico. L’accostamento alla fotografia industriale innesca nello spettatore la predisposizione a una fruizione obiettiva, indirizzandone lo sguardo a una visione distaccata, si potrebbe dire tecnica. Gli edifici sono tutti ripresi dall’esterno, in modo seriale e omogeneo, immersi in una temporalità sospesa, ma che il taglio e il bianco e nero spingono nel passato, nella nostra storia recente (la prima parte potrebbe addirittura dare l’idea di far parte di un progetto di archeologia industriale). Il fatto che gli edifici siano poi ordinati per categoria (negozi, officine, palestre e così via) aumenta questa impressione.
Ma aprendo le pagine ripiegate, di colpo emerge un mondo completamente diverso, che genera una fruizione ugualmente diversa. Si tratta di fotografie a tutta pagina, a colori, di interni popolati da esseri umani di cui spesso non vediamo i volti, quasi sempre inginocchiati in preghiera, con qualche intermezzo, specie verso la fine de libro, in cui vengono ritratti ambienti o oggetti lasciati dalle persone.
Risulta davvero difficile, in un primo momento, capire che quegli interni sono l’altra faccia degli esterni presenti sul recto della pagina. Che quegli ambienti sono collocati dietro la facciata mostrata dalle immagini in bianco e nero. Che basterebbe aprire quelle porte o quelle saracinesche per trovarsi in quei mondi. La prima sensazione è di straniamento. Che tuttavia crea un’efficace contrapposizione tra le due diverse realtà: una facciata anonima, rigorosa, disabitata, fredda ed essenziale nella sua razionalità strumentale finalizzata alla produzione o alla distribuzione di merci, e un interno estremamente colorato, arredato di tappeti, vissuto da un’umanità in posizione di preghiera.
Il doppio registro, fotografie di architettura e reportage sociale, è l’elemento più significativo del libro. Se fosse un reportage formato esclusivamente da fotografie a colori, se documentasse quegli improvvisati luoghi di culto, mancherebbe il contrappunto che invece conferisce significato al tutto: il contrasto tra la funzione originaria di quei luoghi, consona alla loro architettura, e la funzione quasi stravagante a cui sono stati convertiti, amplificandone la natura nascosta, insospettabile, precaria, non riconosciuta, quasi clandestina. Le immagini creano una sorta di schizofrenia visiva. Le fotografie in bianco e nero mostrano ciò che quegli edifici sono, quelle a colori mostrano ciò che essi “fanno”, o meglio, ciò che in essi viene fatto. Architettura e utilizzo non collimano.
Quando vediamo un edificio dall’esterno capiamo immediatamente, senza entrarci dentro, quale funzione assolve e il fine per cui è stato costruito. Se vediamo la facciata di una chiesa, ci aspettiamo che entrando troveremo fedeli seduti o inginocchiati. Edificio, funzione e occupanti sono allineati all’interno non solo di una stessa pratica e di una stessa tradizione, ma anche di una medesima iconografia. Le fotografie di Degiorgis non solo documentano una condizione sociale e culturale stridente, ma stravolgono anche un sedimentato immaginario visivo. Lo stridore, anzi, è tanto più forte perché non limitato al riconoscimento di una disparità delle opportunità di culto riservate agli abitanti di un Paese civile, ma in quanto coinvolge le nostre aspettative visive nell’accostamento degli spazi presentati dalle immagini, quelli esterni e quelli interni, contrapponendo un immaginario architettonico di tipo industriale o commerciale a uno religioso, mettendo insieme fredda indagine topografica e documentazione sociale, richiesta di distacco obiettivo e invito al coinvolgimento e alla presa di posizione.
In un’intervista Degiorgis afferma che il suo intento non era in realtà quello di fare denuncia sociale. La forma del libro infatti è dialettica, finalizzata soprattutto a lavorare sullo sguardo, per provocarne una continua rimodulazione. In Hidden islam Degiorgis obbliga lo sguardo a un’oscillazione continua, a riorientarsi in modo costante, ponendolo a distanza e avvicinandolo, alternando foto piccole con ampia cornice a immagini espanse, visione dall’esterno e collocazione all’interno. È questo andirivieni del punto di vista che conferisce al progetto una valenza critica, non scontata.
L’interesse del libro è proprio nello stridore del confronto tra ciò che sembra e ciò che è, e nel fatto che questo stridore è illustrato in un registro formale che rispecchia appieno quello sociale e politico. Intento documentario e autoriflessivo qui stanno assieme: così il primo si rinnova e il secondo prende sostanza. E il libro stesso, la sua forma e disposizione, diventano oggetto di riflessione e mezzo di trasmissione di contenuti, con un’attitudine concettuale e una soluzione – le pagine ripiegate – semplice quando acuta nella sua funzionalità.
Un’ultima considerazione.
In questi spazi improvvisati i fedeli cercano di riproporre le stesse regole che disciplinano il culto nelle moschee tradizionali, ad esempio la rigida separazione dei posti riservati agli uomini e alle donne. Ma questi spazi così anonimi, poco organizzati a tal fine, dalle architetture povere e scarne, affievoliscono quelle divisioni, conferendo alla pratica religiosa qualcosa di meno artificioso, di più autentico, meno legato alla magnificenza di architetture e di arredi preziosi. Paradossalmente, proprio perché calate in questi luoghi inappropriati e disadorni, queste pratiche di devozione sembrano acquistare un carattere di maggiore intimità e vitalità, come quello che forse caratterizzava le prime comunità cristiane.
***
Parleremo di Hidden Islam assieme a Michele Degiorgis, direttore di Rorhof, venerdì 22 marzo 2019 alle ore 19 alla libreria Verso di Milano, Corso di Porta ticinese 40, nell’ambito del ciclo di incontri “La costruzione dello sguardo / Incontri con editori indipendenti di fotografia”.
A seguire: intervista a Nicolò Degiorgis a cura di ContemporaryArt Torino.














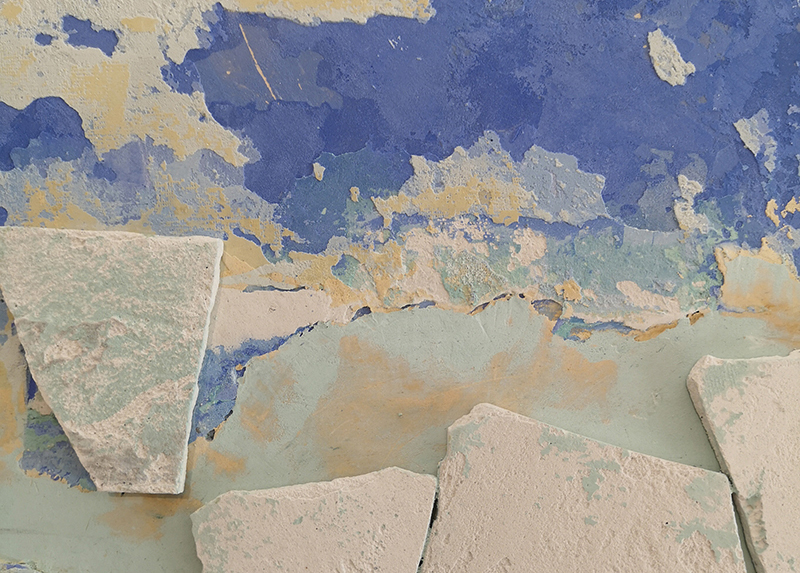


Scrivi un commento